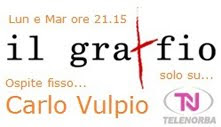Non è chiaro se siamo state recepite le osservazioni del Comune di Spinazzola per salvaguardare la zona
NEL PIANO REGIONALE GROTTELLINE E’ SITO DI DISCARICA O DA TUTELARE?
di Cosimo Forina
Spinazzola-Dopo il trionfalismo a reti unificate per il Piano Paesaggistico partorito dall’assessore alla qualità del territorio Angela Barbanente presentato dal governatore Nichi Vendola al Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, primo in Italia secondo le fonti ministeriali, qualche domanda è d’uopo. E quella che più di altre sta suscitando perplessità è: “che fine hanno fatto le osservazioni al Piano Paesaggistico relative al sito di “Grottelline” presentate dal Comune di Spinazzola che chiedeva la sua salvaguardia?” In pratica il Piano della Barbanente riporta le cave di “Grottelline” ed il sito nelle sue tavole esplicative come “discarica” mentre l’amministrazione Comunale ha impugnato non solo tale individuazione ma con delibera di consiglio Comunale, nei termini stabiliti dalla stessa Regione, ha evidenziando le peculiarità dell’area sottolineandone la sua valenza storica, naturalistica, archeologico, paesaggistica che sono state ignorate dal documento regionale. Il sindaco Nicola Di Tullio ha affermato alla “Gazzetta” che le osservazioni votate dal consiglio Comunale non sono mai state oggetto di analisi ed a sentire la necessità di capirne di più anche il consigliere regionale Ruggiero Mennea schierato contro la discarica a Spinazzola. Mentre Francesco Tarantini di Legambiente, già promotore di altre osservazioni in ambito di conferenza di servizio sul progetto e variante della discarica che si vuole costruire a Grottelline affidata da Nichi Vendola all’Ati Tradeco-Cogeam, pur dicendosi soddisfatto del varo del Piano Paesaggistico non ha escluso di attivarsi per far presentare una interrogazione urgente nei confronti della Barbanente e Vendola: “per capire che fine hanno fatto le osservazioni del Comune di Spinazzola”. Cosa veniva eccepito? Come primo punto, una maggiore valutazione specifica della struttura idrogeomorfologica del sito, per i suoi solchi erosivi di natura carsica, lame, dovuti all’azione naturale di corsi d’acqua di natura episodica. Altro punto rilevante: “la struttura ecosistemica e ambientale”. Il consiglio Comunale osservava che l’area di “Grottelline”: “benché esterna al SIC/ZPS “Murgia Alta”, rientra tuttavia in un ambito di transizione delle aree substeppiche più vaste d’Italia. Permettendo un interscambio tra quelle naturali dell’altopiano murgiano e quelle del versante bradanico”. Terza osservazione: “la struttura antropica e storico-culturale”. Questa comprende l’arco temporale significativo con testimonianze peculiari nei periodi, neolitico, bizantino,normanno-svevo e non solo. La documentazione prodotta in questo caso alla regione comprendeva i vincoli archeologici del sito neolitico scoperto dall’Università di Pisa, nonché la segnalazione in sede dei beni culturali del Documento Preliminare del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia Barletta-Andria-Trani. E qui l’elenco si fa nutrito: presenza di grotte antropiche, la chiesa rupestre a croce greca con cinque absidi, la masseria “Salomone” di pregevole architettura risalente ai secoli XVI-XVII, il Casale di Grottellini, possedimento dei Templari documentato sin dal 1197, costituito da una costruzione centrale, ubicata nel territorio di Poggiorsini, circondata da innumerevoli grotte che concorrono sin al limite della cava che si vuole destinare a discarica alla funzionalità della struttura. Gli ulteriori contesti paesaggistici non contemplati dal Piano della Barbanente sono stati inviati in Regione con gli elaborati grafici, disponibili anche in formato shapeflile, con specifica ubicazione delle strutture descrittive dei caratteri del paesaggio. A tutto questo si aggiunge l’accertata nidificazione nell’area del falco lanario e la presenza di numerose altre specie di fauna e flora di notevole interesse. Nichi Vendola auspicando che la prossima amministrazione regionale faccia proprie le scelte politiche ed esperienze come quella del Piano Paesaggistico, dopo il compiacimento del ministro Franceschini ha cosi commentato: "Nell'Italia del fango, degli eventi meteorologici estremi, della vulnerabilità di un territorio che è ferito mille volte, noi proviamo a voltare pagina e diamo un buon esempio a tutta l'Italia". Se magari vorrà far sapere che fine hanno fatto le osservazioni del Comune di Spinazzola, e quindi quale Piano Paesaggistico è stato portato alla firma del Ministro Franceschini, non sarebbe di certo un male.
domenica 18 gennaio 2015
venerdì 7 novembre 2014
STORIA E SOCIETÀ
PAPA INNOVATORE E IL GESUITA IN CINA
DECISIONE CORAGGIOSA
Spinazzola sta celebrando Antonio Pignatelli, il papa che sradicò il nepotismo dal soglio pontificio
MISSIONARIO POLIGLOTTA
L’opera di Michele Ruggeri in Estremo Oriente fu facilitata dalla sua predisposizione ad imparare le lingue
Da Innocenzo XII a Michele Ruggeri
Spinazzola, la città celebra i suoi figli più illustri
Spinazzola tramite i suoi figli più illustri può dirsi città per la cristianità nel mondo e dell’apprendimento linguistico. Non è questa una esagerata lettura del piccolo centro murgiano incastonato tra la Puglia e la Basilicata. Da questa realtà nei secoli, sorprenderà i più, la fede ha effettivamente raggiunto gli angoli più remoti del globo. Non solo perché qui è venuto alla luce Antonio Pignatelli (Spinazzola 13 marzo 1615-Roma 27 settembre 1700) salito al soglio pontificio con il nome di Innocenzo XII, di cui nel 2015 ci si appresta a celebrare il quattrocentesimo anno dalla nascita. Papa riformatore della Chiesa che abolì il nepotismo.
UN RELIGIOSO AI CONFINI DEL MONDO
Ma anche perché Spinazzola ha dato i natali a Michele Ruggeri (Spinazzola 28 ottobre 1543-Salerno 11 maggio 1607) missionario gesuita, primo sinologo d’Europa ad aver raggiunto la Cina, averla in parte attraversata, imparato a comprendere, parlare, leggere e scrivere la complessa lingua del mandarino usata da letterati, nobili, magistrati in tutto l’impero. Ed a pochi è certamente noto che il primo Catechismo (Ttienciu Sce-lu) scritto e stampato in cinese (novembre 1584) ad opera di un occidentale è stato uno degli scritti del gesuita Ruggeri a cui erano allegati i dieci comandamenti.
Sempre a Ruggeri è altresì attribuita la traduzione e diffusione nella terra del Celeste Impero del Padre Nostro, Ave Maria e Gloria. Tra pochi giorni oltre a ricorrere l’anniversario dalla sua nascita,
battezzato con il nome di Pompilio nella città all’epoca del Regno di Napoli che contava 311 fuochi, 1500 abitanti, acclusa alla diocesi di Venosa, ricorreranno anche i quattrocentotrenta anni dalla pubblicazione del Catechismo stampato nella sua prima edizione in soli 1500 esemplari, di cui una preziosa copia è conservata a Roma. Sebbene più noto tra i missionari giunti in Cina con Michele Ruggeri è Matteo Ricci di origine marchigiane, la Chiesa ha iniziato per il secondo da tempo il processo di beatificazione, figura più nota nella stessa Cina, i due insieme giunsero a Zhaoqing città da dove poi Ruggeri cercò, con non pochi ostacoli ma anche con grande accoglienza della popolazione di giungere a Pechino. Entrambi fratelli dello stesso ordine gesuita fondato da Ignazio di Loyola, la Compagnia di Gesù, con altri undici missionari erano partiti da Lisbona il 24 marzo 1578 per raggiungere l’India. Un viaggio avventuroso durato sei mesi, con la circumnavigazione dell’Africa, conclusosi nel porto di Goa. Dal grande seminario di San Paolo, Ruggeri venne inviato dal provinciale dell’India padre Vincenzo Ruiz a raggiungere altro confratello nel Malabar, attuale stato del Tamil-Nada. Ed anche qui si esercitò nell’apprendere la complessa lingua locale.
DA L L’INDIA A MACAO
Questa sua capacità venne ben presto notata, tanto che a sorpresa il 12 aprile 1579 ebbe ordine dai suoi superiore di partire per Macao, emporio portoghese, per essere mandato in Cina. La conoscenza della lingua era essenziale per assolvere al compito dell’evangelizzazione e li dove altri missionari avevano rinunciato Ruggeri vi riuscì creandosi un proprio metodo di comprensione del tutto originale. Ripreso secoli dopo dal pedagogista belga Ovidio Decroly per diffondere l’apprendimento linguistico. Ruggeri caposcuola filologico. Il missionario spinazzolese infatti, con l’ausilio di un pittore locale suo amico per l’apprendimento associava la figura disegnata (esempio: cavallo) all’ideogramma cinese corrispondente, aggiungendo la romanizzazione italiana del suono.
Nel metodo Decroly-globale alla figura è associata la lettera iniziale del nome in carattere maiuscolo e minuscolo e la scrittura di tutto il nome. Tale metodo è diffuso in tutte le scuole del mondo ove le lingue sono basate sull’alfabeto. L’affinità dei due metodi parte dalla stessa intuizione, quello dell’associazione della figura per l’apprendimento linguistico. In questo modo, il nostro Ruggeri, acquisì cognizioni di 15 mila ideogrammi dei 60-80 mila che compongono l’idioma mandarino, grazie ai quali non solo poté confrontarsi con i nobili ed essere accettato da questi, ma diffuse il vangelo e battezzò diverse famiglie, fondatori delle prime comunità cristiane in terra cinese.
RELIGIOSO MA ANCHE POETA E SCRTTORE
Complessa, straordinaria la storia personale e quella del missionario Michele Ruggeri: poeta, scrittore, dottore in diritto canonico, fondatore di una scuola per l’apprendimento della lingua cinese per stranieri, la Shengma’erding Jingyuan (la casa di San Martino), ma anche autore dell’Atlante della Cina. Nel novembre del 1588 Ruggeri viene inviato a Roma per sollecitare il Papa affinché si provvedesse un’ambasceria pontificia al fine di ottenere per i missionari il permesso di soggiornare
nell’Impero. Un progetto che per il susseguirsi di Papi non fu possibile perseguire. Ruggeri ritiratosi a Salerno, non senza amarezza, dopo i dieci anni trascorsi in Cina, riprese il suo lavoro intellettuale
per rendere più nota in Europa la cultura cinese. Sua la traduzione latina dei Quattro libri (classici testi cinesi sull'introduzione alla filosofia di Confucio), come poesie in cinese e la diffusione delle carte geografiche la cui raccolta e pubblicazione è stata curata solo nel 1993 da Eugenio Lo Sardo (Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato). Il manoscritto originale dell’Atlante della Cina datato 1606 è conservato nella Biblioteca dell’Archivio di Stato di Roma. Spinazzola e la Cina dovrebbero sentirsi più vicine grazie alla figura del gesuita Michele Ruggeri così come lo sono le Marche con Matteo Ricci. Sebbene ancora è tutto molto difficile per la Chiesa cattolica nominare i propri vescovi in Cina. La figura del gesuita Michele Ruggeri incarna quell’essenza che papa Francesco ha rivolto nel suo messaggio al Congresso internazionale sulla Catechesi organizzato nell’Anno della Fede: “La catechesi è un pilastro per l’educazione della fede, e ci vogliono buoni catechisti!”; e per esserlo bisogna “ripartire da Cristo”, che significa “non aver paura di andare con Lui nelle periferie”. E citando Benedetto XVI: “La Chiesa non cresce per proselitismo ma per testimonianza”. Lo spinazzolese Ruggeri è stato testimonianza di fede, pur oggi ancora poco conosciuto, la sua vita patrimonio non solo del territorio che ne diede i natali, egli seppe giungere, oltre quattro secoli fa, oltrepassando i confini del Celeste Impero, nel cuore della gente di Cina
lunedì 20 ottobre 2014
GROTELLINE NUOVA PAGINA
Il governatore della Regione Puglia “a termine” e commissario per l’emergenza ambientale “scaduto”, Nicola Vendola (detto Nichi), si è lavato le mani della questione Grottelline. Lo scorso 14 ottobre ha deciso di passare il cerino acceso ad altri, con una semplice comunicazione. In cui, in modo unilaterale, ha ricostruito la vicenda del mancato avvio dell’immondezzaio da lui concesso all’Ati Tradeco-Cogeam (Gruppo Columella per la Tradeco, al 51 per cento Marcegaglia SpA e 49 per cento Cisa Spa).
Adesso, a dover decidere sulla controversa questione saranno il presidente dell’Oga Bat, Nicola Giorgino, i sindaci dell’Ato/Bat (Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando, Spinazzola, Trani e Trinitapoli) e i superstiti comuni dell’ex Ato Ba/4 (Altamura, Gravina di Puglia, Santeramo e Poggiorsini).
Vendola ha scelto di chiudere in questo modo il suo percorso di ex commissario all’emergenza ambientale in Puglia, proprio a pochi mesi dalla scadenza del suo secondo mandato da presidente della Giunta regionale. Un mandato durato dieci lunghi anni, in cui proprio Grottelline ha rappresentato l’apice del fallimento della Regione nella politica di gestione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Dieci lunghi anni di fatti gravi e rocamboleschi: sparizione di documenti e di memorie del computer nell’assessorato regionale contenenti i dati di Grottelline, “balletti” di numeri sulla reale estensione delle particelle del progetto, varianti dubbie e sequestri giudiziari.
Tutto pur di realizzare una discarica che sconvolgerebbe un sito di interesse archeologico, monumentale, paesaggistico e naturalistico, che proprio l’assessore all’Ambiente, Lorenzo Nicastro, ha inserito nel Piano regionale dei rifiuti, nonostante le innumerevoli sollecitazioni dei Comuni e delle associazioni ambientaliste, e le interrogazioni al Parlamento italiano ed europeo. Un Piano votato a maggioranza in Consiglio regionale non solo dagli adepti di Vendola, ma anche e senza indugio dagli esponenti del Pd, che ora sembrano defilarsi dicendosi contrari. Un Piano sostenuto anche da Michele Emiliano, segretario regionale Pd e probabile candidato alla presidenza della Regione.
Intanto, continuano le indagini della Direzione distrettuale antimafia di Bari sui rifiuti tombati nelle cave e scoperti di recente, che Vendola non menziona nella sua lettera di passaggio delle consegne. Poi, ci sono i ricorsi al Tar dei Comuni di Spinazzola e Poggiorsini, che riguardano la valanga di contraddizioni del Piano paesaggistico partorito dall’assessore Angela Barbanente. Eppure Vendola, dopo che in tutti questi anni ha sparato a zero su chiunque si occupasse di Grottelline contestando le sue “verità”, Come agevolmente si legge anche nei verbali di magistrati: l’ex pm Desireè Digeronimo e negli atti della commissione parlamentare antimafia sul ciclo dei rifiuti presieduta dall’on. Gaetano Pecorella, ha deciso di lavarsene la mani.
Ora su Grottelline si apre un nuovo capitolo, che potrebbe portare, se a prevalere sarà la coerenza, a conclusioni opposte, visto che sia l’Oga, sia i Comuni della Bat, sia la Provincia Barletta-Andria-Trani si sono da sempre dichiarate contrarie alla realizzazione della discarica a Spinazzola. Resta tuttavia un dubbio: nel caso in cui la controversia dovesse protrarsi con la bocciatura dell’immondezzaio a Spinazzola, a chi toccherà, dopo questa fuga della Regione, pagare gli eventuali danni alle imprese?
venerdì 19 settembre 2014
Arena di Verona, 12 settembre 2014.
Dietro le quinte del concerto «In sint(f)onia con il futuro», omaggio musicale dell’Azerbaigian all’Italia: le prove dell’Orchestra italiana del Cinema con i maestri Yalchin Adigezalov e Daniele Belardinelli, di Al Bano e degli artisti azerbaigiani Azer Rzazadeh, Aygun.Straordinaria serata, con oltre 8000 presenze condotta da Carlo Vulpio
Dietro le quinte del concerto «In sint(f)onia con il futuro», omaggio musicale dell’Azerbaigian all’Italia: le prove dell’Orchestra italiana del Cinema con i maestri Yalchin Adigezalov e Daniele Belardinelli, di Al Bano e degli artisti azerbaigiani Azer Rzazadeh, Aygun.Straordinaria serata, con oltre 8000 presenze condotta da Carlo Vulpio
mercoledì 20 agosto 2014
Un viaggio in un Paese straordinario che segnerà il futuro dell'Italia e dell'Europa
Webreportage e fotogallery su:
http://www.corriere.it/reportage/esteri/2014/da-baku-a-brindisi-lungo-la-via-del-gas/
La Via del Gas, dal Caspio all’Adriatico
di Carlo Vulpio
Tutti lo chiamano Corridoio meridionale euroasiatico e sembrano «vederlo» per la prima volta soltanto oggi, ma la linea, quasi una retta, che unisce Brindisi a Baku, la capitale dell’Azerbaigian sulle rive del mar Caspio, è una «strada» che esiste da duemila anni ed è lunga quattromila chilometri.
Terminata la Via Appia, che collegava Roma a Brindisi, cominciava, attraversato il mar Adriatico all’altezza di Durazzo, in Albania, la Via Egnazia, che si fermava alle porte di Istanbul, allora ancora Bisanzio. Da qui, nei secoli successivi alla fondazione di Costantinopoli, «la Nuova Roma» che aveva sostituito Bisanzio, si sarebbero diramate una serie di altre strade verso l’Oriente, tutte rientranti nella mitologica definizione di Via della Seta, che sarebbe diventata famosa con i viaggi di Marco Polo nella seconda metà del 1200. Una di queste Vie della Seta è quella che, appunto, dalla fine della Via Egnazia corre longitudinalmente per tutta la Turchia, fino a Erzurum – Arzen per i Romani, Teodosiopoli per i bizantini e infine Arz-e-Rum, cioè il valore dei Romani, in persiano –, e dopo aver attraversato la Georgia termina in Azerbaigian. Precisamente nella regione del Gobustan, tra i blocchi di pietra millenaria e i meravigliosi petroglifi paleolitici della montagna di Boyukdash, a circa cinquanta chilometri da Baku, dove si trova la prova di quanto stiamo dicendo, una roccia con questa incisione: «All’epoca dell’imperatore Domiziano Cesare Augusto Germanicus. Il centurione Lucio Giulio Massimo, XII Legione Fulminata». L’incisione risale agli anni tra l’84 e il 96 dopo Cristo ed è la più orientale (e quindi la più lontana da Roma) epigrafe latina che si conosca. Probabilmente l’unica in tutto il Caucaso, poiché i Romani si erano spinti fin quaggiù per controllare l’unico passo esistente tra Caucaso meridionale e settentrionale. Insomma, geopolitica anche allora, nulla di nuovo sotto il sole.
La nuova via della seta
Oggi, questo stesso cammino è tornato di grande interesse, ma in senso inverso. Da Baku a Brindisi (o meglio, a Melendugno, Lecce). La stessa Via della Seta, la stessa Via Egnazia, fuse senza soluzione di continuità in un’unica, grande Via del Gas. Il gas dell’Azerbaigian. Uno dei cinque Paesi – con Iran, Russia, Kazakistan e Turkmenistan – che si affacciano sul mar Caspio e che si dividono l’enorme quantità di gas (il 46 per cento delle riserve mondiali) stivato nei suoi fondali. E’ gas metano, di gran lunga il meno inquinante tra i combustibili fossili (non c’è paragone con carbone e petrolio), il più economico, il più facile da trasportare anche attraverso lunghi gasdotti – tubi interrati, anche sotto il fondale marino, del diametro di poco più di un metro -, il più abbondante in natura. Per l’Unione Europea, che è il terzo consumatore mondiale di energia, dopo Usa e Cina, e il cui «paniere energetico» nel 2035 sarà riempito per ben il 30 per cento dal gas, un’ancora di salvezza. Per l’Italia in particolare, che dopo la crisi libica è diventato il primo importatore di petrolio dall’Azerbaigian, un’opportunità doppia, anzi tripla, visto che si potrebbe convertire a gas (anzi, si dovrebbe, in base a un accordo del 2001, governo Prodi) sia la centrale elettrica di Cerano (la più grande d’Europa), sia quella di Brindisi Nord e persino produrre una parte dell’acciaio dell’Ilva con centrali termoelettriche alimentate a gas, già diffuse sia in Azerbaigian, sia nel resto d’Europa. Dice il ministro azerbaigiano dell’Energia, Natig Aliyev: «Questo progetto è davvero la nuova Via della Seta, perché cambia in radice la mappa dell’energia mondiale e porta sul palcoscenico nuovi attori, come il nostro Paese, finora considerato poco e comunque meno di Iraq e Iran».
I giacimenti di gas azerbaigiano del Caspio si chiamano Shah Deniz I e II. Il secondo, ancora tutto da sfruttare, vale non meno di 45 miliardi di dollari. Il gasdotto progettato, e in parte già costruito, è composto da tre «tronconi», BTE (Baku-Tblisi-Erzurum), TANAP (Trans Anatolian Pipeline) e TAP (Trans Adriatic Pipeline). Sarà concluso nel 2018 e già l’anno successivo trasporterà dieci miliardi di metri cubi di gas, che potranno essere raddoppiati. Una quantità di gas pari al 15% dell’attuale consumo annuo dell’Italia (70 miliardi di metri cubi), che potrà quindi aumentare l’impiego di metano al posto di carbone, olio combustibile e petrolio e potrà smistarlo anche ai Paesi vicini, evitando così inutili e dannose perforazioni alla ricerca di petrolio di scarsa qualità in Adriatico e consentendo all’Unione Europea di avere un forno in più (e di quale portata) da cui comprare il pane, senza l’ansia di dover dipendere dal buon cuore della Russia o dalle sorti di Libia e Algeria. Il gasdotto servirà, con altrettante diramazioni, anche i Paesi balcanici e persino Israele e Iran, che certo non si scambiano affettuosità.
Non solo petrolio e gas
Questa Via del Gas però non è soltanto un nuovo asse energetico-commerciale, e quindi geopolitico, della massima importanza. E’ anche un grande canale culturale, un fascio di nervi e di neuroni che per lungo tempo è rimasto pressoché inattivo, e invece percorre e lega due mondi diversi, che da secoli hanno in comune molto più di ciò che essi stessi credono. Che sia stata progettata da diverse società multinazionali riunitesi in consorzio – tra le quali, la società di Stato azerbaigiana Socar – non vuol dire che sia opera del demonio.
Significa, più semplicemente, che oggi sta avvenendo con il gas ciò che, sempre qui, avvenne già ieri, quando, era il 1995, da poco implosa l’Unione Sovietica, l’Azerbaigian inaugurò la cosiddetta «politica delle porte aperte» e per sfruttare al meglio il proprio petrolio (trattenendo per sé il 30 per cento dei ricavi, fatto che è già passato alla storia come «il contratto del secolo») coinvolse nel medesimo consorzio tredici compagnie di otto Paesi diversi, meritandosi l’appellativo di «Onu in miniatura» e assicurandosi così l’indipendenza vera, quella economica, che gli avrebbe procurato anche quella politica. Significa, inoltre, non dimenticare nemmeno ciò che è avvenuto l’altro ieri, quando, meravigliati davanti ai gusher, le fontane spontanee di petrolio che sgorgano dal sottosuolo, si decise di fare la prima trivellazione al mondo (era il 1848), e poi il primo oleodotto (1879), e poi la prima raffineria per ottenere il cherosene, merito del grande Dmitrij Mendeleev, quello della tavola periodica degli elementi, e poi la prima società petrolifera, che i fratelli Robert e Ludwig Nobel, quelli del premio omonimo, crearono proprio a Baku, da dove salpò anche la prima petroliera, che i Nobel chiamarono Zoroaster, perché qui, quindici o forse diciotto secoli prima di Cristo, nacque Zarathustra e da qui si diffuse lo zoroastrismo in tutta la Persia e in gran parte dell’Asia centrale. Con il suo culto del fuoco, forza creatrice e purificatrice. Da cui il nome stesso Azerbaigian, che letteralmente significa «guardiano del fuoco», e la definizione «Terra del Fuoco» che il Paese – centrato in anticipo l’obiettivo Onu, previsto per il 2015, di «riduzione della povertà», dal 49 al 5 per cento -, ha scelto per farsi conoscere all’estero.
Alla scoperta della terra del fuoco
Il fuoco c’è davvero, in Azerbaigian, e brucia spontaneamente sulla terra argillosa della collina di Yanar Dagh, alimentato dal gas invisibile che fuoriesce dal sottosuolo. Uno spettacolo unico, incredibile, che spiega meglio di mille parole perché gli ateshparasti, gli adoratori del fuoco, non potessero che nascere qui. E perché, nonostante il Paese sia musulmano all’85 per cento, i tre quarti dei quali sciiti – benché piuttosto laico per mentalità e Costituzione -, non siano scomparsi.
E’ stato a partire da queste fiamme di questa collina poco fuori Baku, che ci siamo spinti all’interno del Paese – fin quasi al confine con la Georgia, lungo il tragitto del gasdotto che arriverà in Italia – per capire meglio cosa sta succedendo qui, quali nuovi processi si stanno mettendo in moto. Perché una cosa è Baku, con il suo centro storico patrimonio dell’Unesco – il palazzo degli Shirvanshah, la Torre della Vergine -, lo sfavillio delle sue Flame Towers e delle sue architetture ardite e bellissime, con il suo infinito lungomare e la sua contagiosa voglia di vivere, con i suoi boulevard in cui non ce n’è uno che non guidi come un pazzo appena uscito dal manicomio, e poi con i suoi alberghi e i ristoranti e i negozi e persino i pozzi di petrolio che pompano greggio a pochi metri dalle case. Ma un’altra cosa è il resto del Paese, quello più autentico, che certamente è più povero della capitale, però ha più voglia di lei, ha più «fame», e non si accontenta del riconoscimento Unesco che ha inserito i tappeti azerbaigiani nel patrimonio immateriale dell’umanità, né di aver raddoppiato il reddito annuo pro capite negli ultimi sette anni da 3.800 a 7.500 dollari, ma punta, sulla spinta di una crescita «cinese» del pil (15 per cento negli ultimi dieci anni), al tasso zero di povertà e chiede conoscenza, studi, formazione. E apertura al mondo. Si tratti dell’Eurofestival della canzone, tenutosi qui nel 2012, o dei primi Giochi olimpici europei, l’anno prossimo, sempre qui.
Quella azerbaigiana (dieci milioni di persone) è una popolazione giovane – l’età media è di 28,2 anni – che negli ultimi vent’anni, dopo il crollo dell’Urss, è cresciuta di due milioni. Centomila all’anno, e non come media statistica, ma come incremento costante. I fuochi di Yanar Dagh, dunque, bruciano anche altrove, anche oltre il campo petrolifero di Surakhani, uno dei primi e più suggestivi del Paese, un vero museo industriale in attività, dove è vietato riprendere o fotografare e, se lo fai, arrivano i poliziotti (ma abbiamo giocato d’anticipo e per fortuna ci è andata bene).
I fuochi di Yanar Dagh bruciano anche ad Ateshgah, il Tempio del fuoco, ancora affascinante nonostante l’eccessiva opera di restauro, e nel Caravanserraglio che lo circonda, con le sue stele e le sue scritte in persiano, in arabo e in ebraico, con le sue croci cristiane e i suoi cenobi per gli asceti e gli eremiti indù, o le celle in cui i mercanti in viaggio sulla Via della Seta concludevano i propri affari. E’ solo un’anticipazione della pluralità di lingue e di etnie che incroceremo. Ventisei lingue, secondo Strabone, nel solo Azerbaigian, che lui chiama Atropatene, da Atropate, luogotenente di Alessandro Magno nominato satrapo del luogo. E addirittura trenta etnie, se si considera anche l’area del Daghestan, un po’ più a Nord. E quante religioni? Più o meno tutte quelle maggiormente note, in questo crocevia del mondo, disseminate in luoghi di grande bellezza, di raffinato fascino, di antichissima storia, a testimoniare una convivenza, un rispetto e una parità di trattamento codificati anche nelle leggi e difficilmente rintracciabili in altri Paesi islamici e post sovietici. A Baku, con la moschea di Tezepir, la più grande dell’Azerbaigian, che è anche la sede del dipartimento centrale di tutti i musulmani del Caucaso, convive tranquillamente la sinagoga degli «ebrei della montagna» di Guba, mentre a Maraza, di fronte allo stupendo mausoleo del 1402 di Diri Baba, dove chiunque può fermarsi in contemplazione per il tempo che ritiene necessario, si trova uno dei più antichi cimiteri arabi. E a Khanaqa, sul fiume Pirsa’at, nella regione dello Shirvan, c’è un piccolo cenobio sufi tra i più frequentati e venerati del Paese. E poi, più avanti, dopo aver strabuzzato gli occhi davanti ai vulcani di fango, un altro fenomeno naturale unico del sottosuolo azero, ecco la città di Gabala, di cui ancora si vedono le poderose mura romane del I secolo dopo Cristo, e la chiesa di Nich che, assieme a quella bellissima di Kiş, è tra le chiese cristiane albaniche più antiche. Perché anche questo è accaduto qui, che nel Regno di Albània (sorto nel IV-III secolo avanti Cristo, da non confondere con l’odierna Albania) si affermasse il cristianesimo, al punto che l’anno successivo all’editto di Costantino (313 d.C.) qui per la prima volta la religione cristiana venne proclamata religione di Stato. Mentre a Sheki, la città della seta, del meraviglioso palazzo di Sheki Khan dalle finestre di mille colori costruito alla fine del 1700 e del Karavansaray, c’è ancora Tofiq Rasulov che fabbrica le stesse finestre del palazzo del Khan con l’antica tecnica şebeke, cioè quattordicimila pezzi di vetro (all’epoca, provenienti da Venezia) per ogni metro quadrato di finestra, incastrati in minuscoli tasselli di legno senza uso di colla. Infine, Ganja, la più antica capitale dell’Azerbaigian, e Naftalan, il cui nome dice tutto, perché in questa cittadina, fin dai tempi di Marco Polo, vengono da mezzo mondo a fare i fanghi terapeutici immergendosi nel pregiato petrolio locale, che è privo di azoto e paraffina.
Quell’ultimo miglio
Non solo gas, dunque, scorrerebbe nelle condotte della Via del Gas. Eppure, questa grande opera per nulla «impattante» (è un tubo, non un grande rigassificatore) trova l’ostacolo maggiore proprio nell’ultimo tratto – una decina di chilometri -, e proprio in Puglia, cioè la regione dello scempio eolico e fotovoltaico industriali su vasta scala e delle arcaiche centrali a carbone. Il no, che il governo trasformerà in un sì tra un mese, è venuto da quelle stesse istituzioni locali che diedero parere positivo a un altro progetto di gasdotto, poi abbandonato, che doveva approdare a Otranto. Quasi che Otranto fosse meno «delicata» di Melendugno, che fra l’altro è pure nell’entroterra. Nulla di nuovo sotto il sole, dunque. E’ sempre lo stesso Grande gioco dei contrapposti interessi geopolitici. I Romani lo capirono subito e per il Corridoio meridionale euroasiatico tirarono diritto.
Webreportage e fotogallery su:
http://www.corriere.it/reportage/esteri/2014/da-baku-a-brindisi-lungo-la-via-del-gas/
La Via del Gas, dal Caspio all’Adriatico
di Carlo Vulpio
Tutti lo chiamano Corridoio meridionale euroasiatico e sembrano «vederlo» per la prima volta soltanto oggi, ma la linea, quasi una retta, che unisce Brindisi a Baku, la capitale dell’Azerbaigian sulle rive del mar Caspio, è una «strada» che esiste da duemila anni ed è lunga quattromila chilometri.
Terminata la Via Appia, che collegava Roma a Brindisi, cominciava, attraversato il mar Adriatico all’altezza di Durazzo, in Albania, la Via Egnazia, che si fermava alle porte di Istanbul, allora ancora Bisanzio. Da qui, nei secoli successivi alla fondazione di Costantinopoli, «la Nuova Roma» che aveva sostituito Bisanzio, si sarebbero diramate una serie di altre strade verso l’Oriente, tutte rientranti nella mitologica definizione di Via della Seta, che sarebbe diventata famosa con i viaggi di Marco Polo nella seconda metà del 1200. Una di queste Vie della Seta è quella che, appunto, dalla fine della Via Egnazia corre longitudinalmente per tutta la Turchia, fino a Erzurum – Arzen per i Romani, Teodosiopoli per i bizantini e infine Arz-e-Rum, cioè il valore dei Romani, in persiano –, e dopo aver attraversato la Georgia termina in Azerbaigian. Precisamente nella regione del Gobustan, tra i blocchi di pietra millenaria e i meravigliosi petroglifi paleolitici della montagna di Boyukdash, a circa cinquanta chilometri da Baku, dove si trova la prova di quanto stiamo dicendo, una roccia con questa incisione: «All’epoca dell’imperatore Domiziano Cesare Augusto Germanicus. Il centurione Lucio Giulio Massimo, XII Legione Fulminata». L’incisione risale agli anni tra l’84 e il 96 dopo Cristo ed è la più orientale (e quindi la più lontana da Roma) epigrafe latina che si conosca. Probabilmente l’unica in tutto il Caucaso, poiché i Romani si erano spinti fin quaggiù per controllare l’unico passo esistente tra Caucaso meridionale e settentrionale. Insomma, geopolitica anche allora, nulla di nuovo sotto il sole.
La nuova via della seta
Oggi, questo stesso cammino è tornato di grande interesse, ma in senso inverso. Da Baku a Brindisi (o meglio, a Melendugno, Lecce). La stessa Via della Seta, la stessa Via Egnazia, fuse senza soluzione di continuità in un’unica, grande Via del Gas. Il gas dell’Azerbaigian. Uno dei cinque Paesi – con Iran, Russia, Kazakistan e Turkmenistan – che si affacciano sul mar Caspio e che si dividono l’enorme quantità di gas (il 46 per cento delle riserve mondiali) stivato nei suoi fondali. E’ gas metano, di gran lunga il meno inquinante tra i combustibili fossili (non c’è paragone con carbone e petrolio), il più economico, il più facile da trasportare anche attraverso lunghi gasdotti – tubi interrati, anche sotto il fondale marino, del diametro di poco più di un metro -, il più abbondante in natura. Per l’Unione Europea, che è il terzo consumatore mondiale di energia, dopo Usa e Cina, e il cui «paniere energetico» nel 2035 sarà riempito per ben il 30 per cento dal gas, un’ancora di salvezza. Per l’Italia in particolare, che dopo la crisi libica è diventato il primo importatore di petrolio dall’Azerbaigian, un’opportunità doppia, anzi tripla, visto che si potrebbe convertire a gas (anzi, si dovrebbe, in base a un accordo del 2001, governo Prodi) sia la centrale elettrica di Cerano (la più grande d’Europa), sia quella di Brindisi Nord e persino produrre una parte dell’acciaio dell’Ilva con centrali termoelettriche alimentate a gas, già diffuse sia in Azerbaigian, sia nel resto d’Europa. Dice il ministro azerbaigiano dell’Energia, Natig Aliyev: «Questo progetto è davvero la nuova Via della Seta, perché cambia in radice la mappa dell’energia mondiale e porta sul palcoscenico nuovi attori, come il nostro Paese, finora considerato poco e comunque meno di Iraq e Iran».
I giacimenti di gas azerbaigiano del Caspio si chiamano Shah Deniz I e II. Il secondo, ancora tutto da sfruttare, vale non meno di 45 miliardi di dollari. Il gasdotto progettato, e in parte già costruito, è composto da tre «tronconi», BTE (Baku-Tblisi-Erzurum), TANAP (Trans Anatolian Pipeline) e TAP (Trans Adriatic Pipeline). Sarà concluso nel 2018 e già l’anno successivo trasporterà dieci miliardi di metri cubi di gas, che potranno essere raddoppiati. Una quantità di gas pari al 15% dell’attuale consumo annuo dell’Italia (70 miliardi di metri cubi), che potrà quindi aumentare l’impiego di metano al posto di carbone, olio combustibile e petrolio e potrà smistarlo anche ai Paesi vicini, evitando così inutili e dannose perforazioni alla ricerca di petrolio di scarsa qualità in Adriatico e consentendo all’Unione Europea di avere un forno in più (e di quale portata) da cui comprare il pane, senza l’ansia di dover dipendere dal buon cuore della Russia o dalle sorti di Libia e Algeria. Il gasdotto servirà, con altrettante diramazioni, anche i Paesi balcanici e persino Israele e Iran, che certo non si scambiano affettuosità.
Non solo petrolio e gas
Questa Via del Gas però non è soltanto un nuovo asse energetico-commerciale, e quindi geopolitico, della massima importanza. E’ anche un grande canale culturale, un fascio di nervi e di neuroni che per lungo tempo è rimasto pressoché inattivo, e invece percorre e lega due mondi diversi, che da secoli hanno in comune molto più di ciò che essi stessi credono. Che sia stata progettata da diverse società multinazionali riunitesi in consorzio – tra le quali, la società di Stato azerbaigiana Socar – non vuol dire che sia opera del demonio.
Significa, più semplicemente, che oggi sta avvenendo con il gas ciò che, sempre qui, avvenne già ieri, quando, era il 1995, da poco implosa l’Unione Sovietica, l’Azerbaigian inaugurò la cosiddetta «politica delle porte aperte» e per sfruttare al meglio il proprio petrolio (trattenendo per sé il 30 per cento dei ricavi, fatto che è già passato alla storia come «il contratto del secolo») coinvolse nel medesimo consorzio tredici compagnie di otto Paesi diversi, meritandosi l’appellativo di «Onu in miniatura» e assicurandosi così l’indipendenza vera, quella economica, che gli avrebbe procurato anche quella politica. Significa, inoltre, non dimenticare nemmeno ciò che è avvenuto l’altro ieri, quando, meravigliati davanti ai gusher, le fontane spontanee di petrolio che sgorgano dal sottosuolo, si decise di fare la prima trivellazione al mondo (era il 1848), e poi il primo oleodotto (1879), e poi la prima raffineria per ottenere il cherosene, merito del grande Dmitrij Mendeleev, quello della tavola periodica degli elementi, e poi la prima società petrolifera, che i fratelli Robert e Ludwig Nobel, quelli del premio omonimo, crearono proprio a Baku, da dove salpò anche la prima petroliera, che i Nobel chiamarono Zoroaster, perché qui, quindici o forse diciotto secoli prima di Cristo, nacque Zarathustra e da qui si diffuse lo zoroastrismo in tutta la Persia e in gran parte dell’Asia centrale. Con il suo culto del fuoco, forza creatrice e purificatrice. Da cui il nome stesso Azerbaigian, che letteralmente significa «guardiano del fuoco», e la definizione «Terra del Fuoco» che il Paese – centrato in anticipo l’obiettivo Onu, previsto per il 2015, di «riduzione della povertà», dal 49 al 5 per cento -, ha scelto per farsi conoscere all’estero.
Alla scoperta della terra del fuoco
Il fuoco c’è davvero, in Azerbaigian, e brucia spontaneamente sulla terra argillosa della collina di Yanar Dagh, alimentato dal gas invisibile che fuoriesce dal sottosuolo. Uno spettacolo unico, incredibile, che spiega meglio di mille parole perché gli ateshparasti, gli adoratori del fuoco, non potessero che nascere qui. E perché, nonostante il Paese sia musulmano all’85 per cento, i tre quarti dei quali sciiti – benché piuttosto laico per mentalità e Costituzione -, non siano scomparsi.
E’ stato a partire da queste fiamme di questa collina poco fuori Baku, che ci siamo spinti all’interno del Paese – fin quasi al confine con la Georgia, lungo il tragitto del gasdotto che arriverà in Italia – per capire meglio cosa sta succedendo qui, quali nuovi processi si stanno mettendo in moto. Perché una cosa è Baku, con il suo centro storico patrimonio dell’Unesco – il palazzo degli Shirvanshah, la Torre della Vergine -, lo sfavillio delle sue Flame Towers e delle sue architetture ardite e bellissime, con il suo infinito lungomare e la sua contagiosa voglia di vivere, con i suoi boulevard in cui non ce n’è uno che non guidi come un pazzo appena uscito dal manicomio, e poi con i suoi alberghi e i ristoranti e i negozi e persino i pozzi di petrolio che pompano greggio a pochi metri dalle case. Ma un’altra cosa è il resto del Paese, quello più autentico, che certamente è più povero della capitale, però ha più voglia di lei, ha più «fame», e non si accontenta del riconoscimento Unesco che ha inserito i tappeti azerbaigiani nel patrimonio immateriale dell’umanità, né di aver raddoppiato il reddito annuo pro capite negli ultimi sette anni da 3.800 a 7.500 dollari, ma punta, sulla spinta di una crescita «cinese» del pil (15 per cento negli ultimi dieci anni), al tasso zero di povertà e chiede conoscenza, studi, formazione. E apertura al mondo. Si tratti dell’Eurofestival della canzone, tenutosi qui nel 2012, o dei primi Giochi olimpici europei, l’anno prossimo, sempre qui.
Quella azerbaigiana (dieci milioni di persone) è una popolazione giovane – l’età media è di 28,2 anni – che negli ultimi vent’anni, dopo il crollo dell’Urss, è cresciuta di due milioni. Centomila all’anno, e non come media statistica, ma come incremento costante. I fuochi di Yanar Dagh, dunque, bruciano anche altrove, anche oltre il campo petrolifero di Surakhani, uno dei primi e più suggestivi del Paese, un vero museo industriale in attività, dove è vietato riprendere o fotografare e, se lo fai, arrivano i poliziotti (ma abbiamo giocato d’anticipo e per fortuna ci è andata bene).
I fuochi di Yanar Dagh bruciano anche ad Ateshgah, il Tempio del fuoco, ancora affascinante nonostante l’eccessiva opera di restauro, e nel Caravanserraglio che lo circonda, con le sue stele e le sue scritte in persiano, in arabo e in ebraico, con le sue croci cristiane e i suoi cenobi per gli asceti e gli eremiti indù, o le celle in cui i mercanti in viaggio sulla Via della Seta concludevano i propri affari. E’ solo un’anticipazione della pluralità di lingue e di etnie che incroceremo. Ventisei lingue, secondo Strabone, nel solo Azerbaigian, che lui chiama Atropatene, da Atropate, luogotenente di Alessandro Magno nominato satrapo del luogo. E addirittura trenta etnie, se si considera anche l’area del Daghestan, un po’ più a Nord. E quante religioni? Più o meno tutte quelle maggiormente note, in questo crocevia del mondo, disseminate in luoghi di grande bellezza, di raffinato fascino, di antichissima storia, a testimoniare una convivenza, un rispetto e una parità di trattamento codificati anche nelle leggi e difficilmente rintracciabili in altri Paesi islamici e post sovietici. A Baku, con la moschea di Tezepir, la più grande dell’Azerbaigian, che è anche la sede del dipartimento centrale di tutti i musulmani del Caucaso, convive tranquillamente la sinagoga degli «ebrei della montagna» di Guba, mentre a Maraza, di fronte allo stupendo mausoleo del 1402 di Diri Baba, dove chiunque può fermarsi in contemplazione per il tempo che ritiene necessario, si trova uno dei più antichi cimiteri arabi. E a Khanaqa, sul fiume Pirsa’at, nella regione dello Shirvan, c’è un piccolo cenobio sufi tra i più frequentati e venerati del Paese. E poi, più avanti, dopo aver strabuzzato gli occhi davanti ai vulcani di fango, un altro fenomeno naturale unico del sottosuolo azero, ecco la città di Gabala, di cui ancora si vedono le poderose mura romane del I secolo dopo Cristo, e la chiesa di Nich che, assieme a quella bellissima di Kiş, è tra le chiese cristiane albaniche più antiche. Perché anche questo è accaduto qui, che nel Regno di Albània (sorto nel IV-III secolo avanti Cristo, da non confondere con l’odierna Albania) si affermasse il cristianesimo, al punto che l’anno successivo all’editto di Costantino (313 d.C.) qui per la prima volta la religione cristiana venne proclamata religione di Stato. Mentre a Sheki, la città della seta, del meraviglioso palazzo di Sheki Khan dalle finestre di mille colori costruito alla fine del 1700 e del Karavansaray, c’è ancora Tofiq Rasulov che fabbrica le stesse finestre del palazzo del Khan con l’antica tecnica şebeke, cioè quattordicimila pezzi di vetro (all’epoca, provenienti da Venezia) per ogni metro quadrato di finestra, incastrati in minuscoli tasselli di legno senza uso di colla. Infine, Ganja, la più antica capitale dell’Azerbaigian, e Naftalan, il cui nome dice tutto, perché in questa cittadina, fin dai tempi di Marco Polo, vengono da mezzo mondo a fare i fanghi terapeutici immergendosi nel pregiato petrolio locale, che è privo di azoto e paraffina.
Quell’ultimo miglio
Non solo gas, dunque, scorrerebbe nelle condotte della Via del Gas. Eppure, questa grande opera per nulla «impattante» (è un tubo, non un grande rigassificatore) trova l’ostacolo maggiore proprio nell’ultimo tratto – una decina di chilometri -, e proprio in Puglia, cioè la regione dello scempio eolico e fotovoltaico industriali su vasta scala e delle arcaiche centrali a carbone. Il no, che il governo trasformerà in un sì tra un mese, è venuto da quelle stesse istituzioni locali che diedero parere positivo a un altro progetto di gasdotto, poi abbandonato, che doveva approdare a Otranto. Quasi che Otranto fosse meno «delicata» di Melendugno, che fra l’altro è pure nell’entroterra. Nulla di nuovo sotto il sole, dunque. E’ sempre lo stesso Grande gioco dei contrapposti interessi geopolitici. I Romani lo capirono subito e per il Corridoio meridionale euroasiatico tirarono diritto.
giovedì 14 agosto 2014
In città il ricordo di don Pierino dove uno dei suoi figli nell’amore, Antonio Cicorella, fondò la comunità
LA COMUNITÀ «CASA MICHELE» PIANGE LA MORTE DI DON GELMINI
La struttura di accoglienza è fra i primi centri creati dall’organizzazione
di Cosimo Forina
SPINAZZOLA . «Il Don è morto». Prima ancora che le agenzie battessero la notizia il messaggio con tutto il suo carico di dolore partito da Mulino Silla nella città di Amelia, in provincia di Terni, della scomparsa di don Pierino Gelmini fondatore della Comunità Incontro, ha raggiunto anche Spinazzola. Nella città dove uno dei suoi figli nell’amore, Antonio Cicorella, aveva fondato agli inizi degli anni novanta, dopo il suo riscatto proprio nella Comunità Incontro, nell’ex Lazzaretto, uno dei primi centri di accoglienza in Italia “Casa Michele”. Un riferimento per ragazzi tossicodipendenti che giungevano dalla strada e da dove in tanti sono partiti per trovare attraverso il
“don” come tutti i ragazzi lo chiamavano, il padre che li avrebbe aiutati a ritrovare attraverso principi e valori un nuovo orientamento della vita.
Il legame con don Pierino e Spinazzola era iniziato nel 1986, quando i primi ragazzi, tra cui Antonio Cicorella, venivano aiutati da alcuni volontari per essere da lui accolti dopo aver fatto i primi colloqui in una delle sedi della Comunità Incontro, quella di Andria, a cui don Gelmini era molto legato. Poi l’inaspettata scelta ultima di vita di Antonio Cicorella, scomparso nel 1995, il quale con alcuni amici apriva le porte di un edificio in abbandono, luogo di desolazione e dolore per trasformarlo in casa calda e accogliente. Ed in meno di tre anni dal 1992 al 1995 ad essere ospitati sono stati ben in 110 a quel tempo giovani disorientati, oggi uomini reinseriti, i più, a pieno titolo nella società. Alcuni fortificati e diventati orientamento per altri ragazzi in difficoltà.
Due le visite a Spinazzola di don Pierino Gelmini, la prima l’8 settembre 1995 in forma strettamente privata quando tra le lacrime dei presenti volle venire a salutare per l’ultima volta Antonio e il 10 ottobre 2004 quando veniva premiato con l’iniziativa legata al libro “Antonio-storia di un Uomo” prefazione curata proprio da don Pierino che ripercorre la storia di Antonio Cicorella e Casa Michele. Dai cui proventi era stato istituito un riconoscimento a chi si occupava di sostegno ai malati di Aids con particolare attenzione ai bambini.
Dal 1963 giorno in cui don Pierino Gelmini incontra a piazza Navona (Roma) Alfredo Nunzi che gli chiede di aiutarlo la vita del prete cambia. Sino a diventare rinuncia alla stessa carriera ecclesiastica per dedicarsi ai diseredati, tossicodipendenti, alcolisti e quanti si riconoscevano nella sua Comunità. Un esercito di oltre quattrocentomila giovani che con le loro famiglie in questi quarant’anni non lo hanno dimenticato e che entrati in Comunità segnati sulle loro braccia sono ripartiti segnati dal “don” nel cuore. Che la terra ti sia lieve, don Pierino. Anche Spinazzola non ti dimenticherà.
venerdì 11 luglio 2014
Anche questo è nei faldoni storici della discarica che si vuole costruire a Grottelline dove da giorni si continua a scavare per riportare alla luce rifiuti tombati.
di Carlo Vulpio
http://carlovulpio.wordpress.com/
A ciascuno il suo factotum. Archinà per Vendola. Petronella per Carofiglio. Voti ed elogi a governatori e scrittori per mancanza di prove
Peccato che si arrivi a conoscere certe cose sempre «dopo», ma ora sappiamo che la Tradeco, azienda leader di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Sud Italia e non solo, consorziata con la Cogeam della signora Emma Marcegaglia (ex presidente Confindustria e attuale presidente Eni), faceva la campagna elettorale non soltanto per Nicola Vendola di Sel (definito dalla Marcegaglia «il miglior governatore regionale d’Italia», e ti credo…), ma anche per il magistrato e poi senatore del Pd, nonché scrittore (per mancanza di prove), Gianrichetto Carofiglio.
Correva l’anno 2008 e c’era la campagna elettorale per le elezioni politiche. E tra Spinazzola e Poggiorsini (Puglia, provincia di Barletta-Andria-Trani) Cogeam-Tradeco voleva a tutti i costi una discarica in contrada Grottelline, tra un sito neolitico, una masseria dei Templari e una sorgente di acqua minerale.
In verità, quella discarica, i soggetti su citati e i loro aedi in Regione Puglia (l’altro magistrato-assessore Lorenzo Nicastro e la irriconoscibile urbanista Angela Barbanente) la vogliono ancora, ma sono tanti gli imbrogli, e le carte truccate, e le perizie contrarie, e persino i furti (intere memorie trafugate dai computer degli uffici regionali), che difficilmente lo sciagurato progetto verrà realizzato. A meno che Vendola&C non mandino lì i carri armati. Ma negli ultimi tempi, vista la mala parata, come e peggio delle sue risatacce a telefono con il factotum dell’Ilva, Girolamo Archinà, a cui faceva i complimenti per aver strappato di mano il microfono a un cronista che chiedeva conto ai Riva dei morti di cancro a Taranto e dell’inquinamento dell’Ilva, Vendola sembra voler tornare sui propri passi e, forse, addirittura fermare il progetto di discarica per il quale si era battuto anima e corpo, fino ad affermare il falso e a lanciare accuse false e infamanti nei confronti di chi osava dissentire e raccontare una storia molto, ma molto diversa da quella che propinava lui. Staremo a vedere. Speriamo.
Ma Gianrichetto Carofiglio, ormai ex magistrato (ecco, questa è forse l’unica cosa buona che ha fatto: dimettersi dalla magistratura) cosa c’entra con la discarica di Grottelline? Diciamolo subito, non c’entra nulla. Né è una colpa che Carofiglio sia molto amico di Vendola, il quale è anche molto amico della moglie di Carofiglio, Romana Pirrelli, un altro magistrato, pm nello stesso distretto giudiziario del marito oltre che nella circoscrizione in cui l’ex magistrato fu eletto. Pirrelli però si teneva per anni nel cassetto le querele contro Vendola (la mia, per esempio, e proprio, ohibò, sui fatti di Grottelline) e le tirava fuori per astenersi dal trattare il caso solo quando costretta da un esposto inviato al procuratore generale. Ma poiché le colpe delle mogli non possono ricadere sui mariti, anche questa non è una colpa dell’ex magistrato, ex senatore e, speriamo, anche ex scrittore. E nemmeno essere stato sostenuto in campagna elettorale da Tradeco è una colpa. Basta saperlo, così magari un elettore si regola e un cittadino comprende meglio la storia e la geografia (politica e non solo).
La colpa di Carofiglio è un’altra. Come apprendiamo solo adesso da alcune intercettazioni telefoniche «sepolte» tra le migliaia di pagine relative all’inchiesta – in verità, alquanto farraginosa – su sanità e rifiuti in Puglia, anche per Gianrichetto, come Archinà per Vendola, durante la campagna elettorale del 2008 si muoveva un altro factotum, Franco Petronella della Tradeco. Il quale, per le “cene autofinanziate” con il candidato Carofiglio rompe le palle via telefono a mezzo mondo affinché si stampino e affiggano manifesti, si mandino in onda spot in radio e in tv e soprattutto si acquistino biglietti a decine «per riempire la sala» e così dar prova di visibile sostegno al candidato-magistrato (allora, lo era ancora), nonché scrittore (sempre per mancanza di prove).
Anche qui, se fai raccolta fondi e lo dichiari (anche se purtroppo in Italia non abbiamo il fund raising come negli Stati Uniti), nessuno obietterebbe. Ma se ricorri, o fai in modo che qualcuno ricorra «a tua insaputa», a questi giochi di sponda, allora rischi di collocarti tra la quarta e la quinta categoria umana de Il giorno della civetta, grande libro del grande scrittore (lui, sì) Leonardo Sciascia (insomma, non è bello oscillare tra i pigliainculo e i quaquaraquà). E tuttavia, nemmeno in questo sta la colpa più grave di Carofiglio. La sua grande, grandissima colpa è nel non aver tenuto conto della «recensione», in questo caso telefonica, di Petronella. E infatti, ecco cosa dice il factotum di Tradeco su Carofiglio: «Domani sera, se non posso portare le persone, la massa a Carofiglio… Ma tu vuoi fare una cosa d’élite…! I libri in campagna elettorale…! Uaglio’…». Ecco. Si fa tanto per diventare scrittore. E poi arriva Petronella.
di Carlo Vulpio
http://carlovulpio.wordpress.com/
A ciascuno il suo factotum. Archinà per Vendola. Petronella per Carofiglio. Voti ed elogi a governatori e scrittori per mancanza di prove
Peccato che si arrivi a conoscere certe cose sempre «dopo», ma ora sappiamo che la Tradeco, azienda leader di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Sud Italia e non solo, consorziata con la Cogeam della signora Emma Marcegaglia (ex presidente Confindustria e attuale presidente Eni), faceva la campagna elettorale non soltanto per Nicola Vendola di Sel (definito dalla Marcegaglia «il miglior governatore regionale d’Italia», e ti credo…), ma anche per il magistrato e poi senatore del Pd, nonché scrittore (per mancanza di prove), Gianrichetto Carofiglio.
Correva l’anno 2008 e c’era la campagna elettorale per le elezioni politiche. E tra Spinazzola e Poggiorsini (Puglia, provincia di Barletta-Andria-Trani) Cogeam-Tradeco voleva a tutti i costi una discarica in contrada Grottelline, tra un sito neolitico, una masseria dei Templari e una sorgente di acqua minerale.
In verità, quella discarica, i soggetti su citati e i loro aedi in Regione Puglia (l’altro magistrato-assessore Lorenzo Nicastro e la irriconoscibile urbanista Angela Barbanente) la vogliono ancora, ma sono tanti gli imbrogli, e le carte truccate, e le perizie contrarie, e persino i furti (intere memorie trafugate dai computer degli uffici regionali), che difficilmente lo sciagurato progetto verrà realizzato. A meno che Vendola&C non mandino lì i carri armati. Ma negli ultimi tempi, vista la mala parata, come e peggio delle sue risatacce a telefono con il factotum dell’Ilva, Girolamo Archinà, a cui faceva i complimenti per aver strappato di mano il microfono a un cronista che chiedeva conto ai Riva dei morti di cancro a Taranto e dell’inquinamento dell’Ilva, Vendola sembra voler tornare sui propri passi e, forse, addirittura fermare il progetto di discarica per il quale si era battuto anima e corpo, fino ad affermare il falso e a lanciare accuse false e infamanti nei confronti di chi osava dissentire e raccontare una storia molto, ma molto diversa da quella che propinava lui. Staremo a vedere. Speriamo.
Ma Gianrichetto Carofiglio, ormai ex magistrato (ecco, questa è forse l’unica cosa buona che ha fatto: dimettersi dalla magistratura) cosa c’entra con la discarica di Grottelline? Diciamolo subito, non c’entra nulla. Né è una colpa che Carofiglio sia molto amico di Vendola, il quale è anche molto amico della moglie di Carofiglio, Romana Pirrelli, un altro magistrato, pm nello stesso distretto giudiziario del marito oltre che nella circoscrizione in cui l’ex magistrato fu eletto. Pirrelli però si teneva per anni nel cassetto le querele contro Vendola (la mia, per esempio, e proprio, ohibò, sui fatti di Grottelline) e le tirava fuori per astenersi dal trattare il caso solo quando costretta da un esposto inviato al procuratore generale. Ma poiché le colpe delle mogli non possono ricadere sui mariti, anche questa non è una colpa dell’ex magistrato, ex senatore e, speriamo, anche ex scrittore. E nemmeno essere stato sostenuto in campagna elettorale da Tradeco è una colpa. Basta saperlo, così magari un elettore si regola e un cittadino comprende meglio la storia e la geografia (politica e non solo).
La colpa di Carofiglio è un’altra. Come apprendiamo solo adesso da alcune intercettazioni telefoniche «sepolte» tra le migliaia di pagine relative all’inchiesta – in verità, alquanto farraginosa – su sanità e rifiuti in Puglia, anche per Gianrichetto, come Archinà per Vendola, durante la campagna elettorale del 2008 si muoveva un altro factotum, Franco Petronella della Tradeco. Il quale, per le “cene autofinanziate” con il candidato Carofiglio rompe le palle via telefono a mezzo mondo affinché si stampino e affiggano manifesti, si mandino in onda spot in radio e in tv e soprattutto si acquistino biglietti a decine «per riempire la sala» e così dar prova di visibile sostegno al candidato-magistrato (allora, lo era ancora), nonché scrittore (sempre per mancanza di prove).
Anche qui, se fai raccolta fondi e lo dichiari (anche se purtroppo in Italia non abbiamo il fund raising come negli Stati Uniti), nessuno obietterebbe. Ma se ricorri, o fai in modo che qualcuno ricorra «a tua insaputa», a questi giochi di sponda, allora rischi di collocarti tra la quarta e la quinta categoria umana de Il giorno della civetta, grande libro del grande scrittore (lui, sì) Leonardo Sciascia (insomma, non è bello oscillare tra i pigliainculo e i quaquaraquà). E tuttavia, nemmeno in questo sta la colpa più grave di Carofiglio. La sua grande, grandissima colpa è nel non aver tenuto conto della «recensione», in questo caso telefonica, di Petronella. E infatti, ecco cosa dice il factotum di Tradeco su Carofiglio: «Domani sera, se non posso portare le persone, la massa a Carofiglio… Ma tu vuoi fare una cosa d’élite…! I libri in campagna elettorale…! Uaglio’…». Ecco. Si fa tanto per diventare scrittore. E poi arriva Petronella.
Iscriviti a:
Post (Atom)